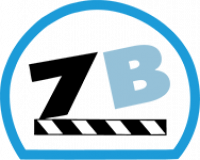Titolo originale: Id.
Léo e Remi, tredicenni della provincia fiamminga, sono uno, all’inizio del film, inseparabili, hanno un’intimità e una complicità innocenti e assolute. Giocano nei campi di fiori recisi dei genitori del primo, giocano insieme battaglie contro nemici invisibili, dormono insieme e si risvegliano guardandosi negli occhi. La tenerezza che li unisce è un dato acquisito e deproblematizzato anche dalle loro famiglie. Ma quando cominciano a frequentare una nuova scuola, nuovi sguardi, nuovi tentativi di definizione di quell’unità incrinano il rapporto tra i due amici. O meglio, spingono Léo a cercare di adattarsi, finendo per rompere quell’uno. Quando questo accade, per Remi suona come una tremenda condanna, e Léo non sembra in grado di gestirne le conseguenze. È vero, Léo e Remi sono presentati come due adolescenti di una bellezza estrema, su di loro i segni della maturazione, della caratterizzazione sessuale secondaria non sono ancora rintracciabili, la fotogenia, la freschezza che sprigiona dai loro volti, ripresi spesso in primissimo piano li rende quasi impossibili, angelici. Ma d’altra parte sul sesso degli angeli si è dibattuto per secoli. Sembrano appunto due angeli quasi alla Van Eyck, Léo e Remi: Dhont è nato e cresciuto a Gand, dove il confronto con l’Altare dell’Agnello mistico del pittore fiammingo, crocevia assoluto di realtà e trascendenza, si può ammirare nella Cattedrale di San Bavone tutti i giorni. I primi piani di Remi che suona l’oboe gonfiando le guance, di Léo che cerca di imitarlo, sembrano scendere direttamente da quelle tavole. Adamo, Eva, il paradiso terrestre, l’Agnello, e i cori di angeli, ci sono perfino i fiori, in abbondanza. Per dire che forse da questo film non dobbiamo pretendere realismo assoluto. È un paradiso terrestre dal confine immateriale, in fondo, quello in cui vivono Léo e Remi – paradeisos in greco è innanzitutto recinzione, giardino – ed è la loro innocenza a essere messa al centro. È quella condizione di vicinanza (e chiusura) evocata dal titolo a essere perduta, irrimediabilmente. Un paradiso perduto. Certo, rimane fuori dall’orizzonte definito dal film il fatto che la scoperta del sesso, con la pubertà, sia a sua volta una frattura ineluttabile, il riconoscimento dell’impossibilità per molti versi di quell’uno, la perdita proprio di quell’innocenza, il necessario confronto con l’altro. Dhont si concentra su un non dichiarato processo alle intenzioni, su una rottura della relazione tra i protagonisti, del recinto del paradiso, a monte del problema della pubertà; una perdita che comincia nel momento in cui una condizione vissuta in maniera naturale e spontanea viene definita e categorizzata dal mondo esterno, quando qualcuno sente la necessità di trovarle un nome: “fidanzati”, “gay”, “froci”. E noi spettatori, che fino a quel momento ne abbiamo seguito la descrizione intima, in piani ravvicinati (close-up), siamo sicuri, noi, progressisti, illuminati, solidali, di non aver pensato a quella categoria, a quei nomi? Il film di Dhont è un po’ questo, un j’accuse rivolto a noi, che siamo ancora, volenti o nolenti, aggrappati a quei nomi, a quegli aggettivi, a quelle categorie: un invito a riflettere sulle radici culturali e semantiche dell’omofobia, quelle che rapidamente si fanno strada, interiorizzate, nei silenzi di Léo. «Lo ha fatto per colpa mia». Potrebbe succedere di nuovo, per colpa nostra.