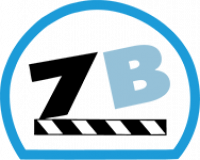Titolo originale: Retour à Séoul
VENERDI' 26 MAGGIO: V.O. SOTTOTITOLATA
Ci sono parabole che sembrano così lineari da far venire voglia di contraddirle, di tirarle giù dai binari su cui sembrano poggiate per cercarne il senso più profondo. A costo di incassare qualche scossone, o qualche salto di racconto imprevisto. Quella di Freddie, nome coreano Yeon-Hee (cioè “Docile e gioiosa”), è una di queste parabole che sembrano seguire un percorso obbligato solo per discostarsene meglio. Nata in Corea ma cresciuta da genitori adottivi francesi, bellezza antica e sfrontatezza moderna, Freddie (Park Ji-min) arriva a Seul “per caso”, o almeno così dice alla sua famiglia francese, perché il suo volo per Tokyo è stato cancellato quando era già all’aeroporto. Ma naturalmente una volta giunta - per la prima volta - nella sua terra natale, non resiste alla tentazione di andare in cerca dei genitori biologici. Impresa tutt’altro che peregrina in un paese che fra il 1958 e il 2004 ha concesso 221.000 adozioni internazionali, dunque ha messo a punto un dettagliato protocollo per i nativi di ritorno in cerca delle proprie radici. Questa però è solo la rampa di lancio di un viaggio che sarà più lungo e accidentato del previsto. Non tanto sul piano dei fatti quanto su quello interiore, assai più sfuggente. Cosa voglia Freddie/Yeon-Hee da quel padre pieno di sensi di colpa rimasto nel suo paesino di pescatori, non lo sa bene nemmeno lei. E cosa debba fare per sfuggire un dolore che non è il suo, senza però rimuoverlo né ignorarlo, è impresa ancora più ardua che la giovane franco-coreana affronta con i soli mezzi che ha, quelli concessi dal suo carattere e dalla sua generazione. Grande facilità (o meglio velocità) di rapporti; gusto occidentale della provocazione, tanto più efficace perché proveniente da una ragazza apparentemente uguale a tutte le altre; elevata capacità di manipolazione, come accade a chi per schivare sentimenti troppo forti si fabbrica una corazza di cui poi non sa più liberarsi. Così la parabola di Freddie finisce per abbracciare l’intera giovinezza, attraverso passaggi che talvolta possono suonare arbitrari (amori iniziati e troncati, amicizie improvvise ma effimere, un mercante d’armi francese un po’ mentore un po’ “sugar daddy”) ma hanno la necessità contorta e segreta della psiche. E finiscono per condurre protagonista e spettatori verso una soluzione aperta, disagevole ma profonda, come l’armonia nascosta nella partitura che Freddie suona, senza conoscerla, nel finale. Elaborando la storia vera di un’amica coreana, con tutte le ellissi e le cesure del caso, il regista Davy Chou, cresciuto in Francia da esuli cambogiani, ha scoperto a film finito di aver parlato quasi solo di sé. Non è poi così sorprendente.
Fabio Ferzetti, da L’Espresso