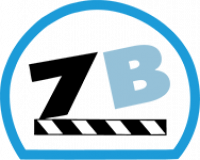Titolo originale: The Old Oak
I film della coppia Loach/Laverty hanno una matrice ideologica che sta tra Marx e Rousseau: gli esseri umani sarebbero di loro natura buoni, gentili, affettuosi, anche se non mancano conflitti individuali dettati da gelosie, rivalità, ambizioni. A un certo punto, però, gli individui o le comunità sono costrette a scontrarsi con una società malvagia che spesso li priva dei loro diritti fondamentali, soprattutto nel campo del lavoro, fattosi sempre più volatile, raro e incerto in un sistema capitalistico ormai privo di ogni regola. Una deregulation che Loach e Laverty hanno indagato in tutte le sue declinazioni, a partire da Riff Raff (1991, si era appena conclusa l’era della Thatcher): fine delle garanzie sindacali, abbattimento del sistema sanitario, immigrazione, precarizzazione. Anche in The Old Oak i conflitti sono determinati da tensioni e traumi di natura sociale, ma con una novità sostanziale: siamo nel 2016, l’anno della crisi siriana, e un gruppo di profughi approda nel nord dell’Inghilterra, in un villaggio in piena decadenza, perché un tempo c’era una cava/miniera che dava lavoro e forniva identità. Ma la cava è stata chiusa e il villaggio è diventato una ghost town senza anima e senza luoghi di aggregazione tranne, appunto, il pub The Old Oak, peraltro anch’esso ormai deserto. Ma il pub possiede, sul retro, un’ampia sala, ora chiusa e polverosa, la cui riapertura diventerà il luogo di scontro/incontro su cui si dipana la storia. Una storia che oscilla tra un atroce pessimismo, tristi ricordi, malinconiche testimonianze, ma pure qualche barlume di speranza nella rinascita di una scintilla di solidarietà e comunità. L’arrivo dei profughi mette in moto infatti due spinte uguali e contrapposte: da un lato, l’arroccamento degli abitanti più retrivi che rifiutano l’Altro, il diverso, la riaffermazione di una identità etnica di natura aggressivamente difensiva; dall’altro, l’apertura a un dialogo, a una condivisione, nella convinzione che l’accettazione del diverso sia l’unico modo per portare nuova linfa a una comunità ormai disseccata. Il film è il racconto di questo conflitto e di come, in realtà, esso sia assai complicato da gestire e quasi impossibile da risolvere (Loach e Laverty mostrano qui la consueta lucidità politica, si guardano bene dall’offrire facili vie di soluzione, anche se ovviamente si schierano con la logica dell’apertura e dell’inclusione). Non è un caso che alcune delle scene migliori del film siano quelle in cui, per qualche istante, si esce dal cupo pessimismo di fondo e si fanno intravvedere scampoli di un’altra vita possibile: la visita di Jari nella cattedrale di Newcastle, in cui la ragazza percepisce lo sforzo comune enorme profuso da migliaia di persone per erigere una tale maestosa architettura; la proiezione nelle sala del pub delle fotografie in bianco e nero che fissano attimi e personaggi della cittadina ridando ad essa una nuova identità e significanza; la creazione dal nulla di una mensa per i poveri. Questi momenti infrangono a tratti il pessimismo nei confronti di una società in cui non v’è castigo per chi sbaglia, né consolazione per chi, al contrario, ogni giorno fa del suo meglio per rendere il mondo in cui viviamo un posto migliore. Nel film sono innanzitutto e soprattutto le donne, i personaggi femminili, le prime a tentare di tracciare un solco di unione e non di divisione. Tirando le somme, questo di Loach, che a dir suo sarebbe l’ultimo, è un film che traccia una vera e propria parabola antropologica di grande acume e di grande interesse per noi, qui ed ora: come in un ologramma, da una parte si può derivare il tutto. Un ruvido neorealismo domina l’opera (c’è pure una citazione/omaggio al celebre finale di Umberto D. di De Sica/Zavattini, quando una cagnetta salva un quasi-suicida): ne emerge la radiografia di un essere umano capace, nel contempo, delle più impensabili cattiverie e bassezze e delle più squisite generosità e slanci d’altruismo.
Alberto Morsiani